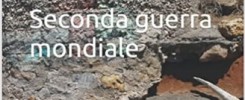Estratto dal libro di Luca Lestingi:
“45 giorni e 80 anni: dal 25 luglio all’8 settembre 1943 passando per l’oggi – Come non abbiamo ancora superato gli eventi di quel periodo”
[ … ]
Era una notte buia e tempestosa, di tregenda…
in realtà era una serata quasi come quella di oggi, dopo 80 anni, un po’ meno calda ma molto umida nel centro di Roma, un’afa appiccicosa e col ponentino che non arrivava, con tanti condizionatori accesi come oggi, ma quelli erano a forma di gerarchi fascisti, condizionatori delle vite di milioni di donne e uomini…
in effetti la tempesta ed il buio da lì a poco ci sarebbero stati, netti, invalicabili, che avrebbero segnato solo l’inizio di una tragedia che devasterà l’Italia, le città come i piccoli borghi…tutti e tutto risucchiati in una follia di devastazione e sangue senza fine…
e i diavoli dannati veramente c’erano, da ombre nere sullo sfondo a protagonisti di una trama senza il “certo” fine, i diavoli dannati a Palazzo Venezia si presentarono in 28, con la testa piena di ogni pensiero, di ogni illusione, di distorsioni verbose di quel loro fare la storia, nolenti o volenti, ma incapaci di indirizzare a loro favore una via ormai smarrita… di amore al fascismo, al loro Duce, ma anche di amore ad una loro idea astrusa di salvare la Patria… gli uni contro l’altri per far valere i propri principi e i loro privilegi, dimentichi di quel popolo che sarebbe dovuto risorgere con la “rivoluzione fascista”…
28 più “uno” … succube della sua stessa vanagloria, in preda alle sue continue e devastanti ulcere di stomaco… la sua guerra nella guerra… piegato in due forse anche più dagli stupri verbali di Hitler come nell’ultimo incontro a Feltre che lo aveva annichilito e soffocato…
[ … ]
A seguito della catastrofica situazione dell’Italia in campo economico, sociale e militare (come trattato nel precedente capitolo) e della sudditanza da Hitler e dalla Germania, Mussolini non fu più in grado di più dettare la linea di governo dell’Italia.
Dino Grandi, presidente della Camera dei fasci e delle corporazioni, con l’appoggio di altri gerarchi riuscì a convincere il Duce di riunire il Gran Consiglio.
La portata di quel 25 luglio è ancora poco valutata. Abituati oggi a continui cambi di governo, abituati a sentire tutti che parlano e che si riuniscono, quella convocazione del 25 sembra scontata. Eppure fu un evento nell’evento.
Perchè il Duce accettò ob torto collo di riunire il Gran Consiglio dopo che per quasi 4 anni non veniva convocato? (L’ultima volta che venne convocato il Gran Consiglio fu nel 07/12/1939, subito dopo l’invasione della Polonia da parte dei Germanici, per dichiarare la non belligeranza dell’Italia).
La figuraccia in Francia e Grecia, la disfatta in Russia, la perdita delle colonie africane AOI e di tutta l’Africa del nord terminata con il ricovero per esaurimento nervoso di Rommel e la fuga dalla Tunisia, la sconfitta di Pantelleria, la “perla nera del mediterraneo”, dichiarata inespugnabile, lo sbarco e la rapida conquista della Sicilia da parte degli angloamericani che dovevano essere fermati sul “bagnasciuga”, il bombardamento del quartiere San Lorenzo a Roma del 19 luglio con più di 3000 morti e i numerosi bombardamenti ormai incontrastabili nelle altre città italiane (Genova, Milano, Torino, Napoli, Palermo, Foggia, Cagliari, Brindisi,…) la lista degli insuccessi era diventata pesante e lunga, come era lunga la lista delle privazioni socio-economiche che gli italiani stavano patendo… Si precisa che la richiesta della riunione fu presentata il 16 luglio, anche prima del bombardamento a Roma. Era pertanto divenuto impossibile a Mussolini negare il confronto ai suoi gerarchi.
Il rimpallo di colpe degli insuccessi militari ai suoi generali non poteva andare più avanti, era stato un grimaldello per anni che ora si era frantumato. Forse anche Mussolini quella sera sperava in una sponda per una via d’uscita da quel disastro, uno spiraglio di sollievo dall’oppressivo amico/padrone Fuhrer… forse pensava di cavarsela con l’ennesimo rimpasto di governo… forse chissà sperava anche lui nella sua destituzione come medicina dalle ulcere e tornarsene nella sua Romagna…
[ … ]
Nella notte tra il 24 e il 25 luglio il Gran Consiglio del Fascismo approvò, con 19 voti favorevoli, 8 contrari e 1 astenuto, l’ordine del giorno presentato da Dino Grandi che poneva la decisione di esautorare Mussolini dalle funzioni di capo del governo.
I 28 componenti del Gran Consiglio furono chiamati a votare per appello nominale, niente voto segreto, non era più tempo di nascondersi. Il dado era nuovamente tratto.
La votazione sull’ordine del giorno Grandi si configurò nel seguente modo:
n.19 (diciannove) voti a favore della destituzione:
1. Giacomo Acerbo (Loreto Aprutino 1888 – Roma 1969) Deputato e Ministro delle finanze Fu condannato a morte in contumacia dal tribunale di Verona istituito dalla RSI nel gennaio 1944 Condannato a 30 dal governo Bonomi, poi amnistiato Morto per morte naturale nel 1969 Foto Wikipedia | |
2. Umberto Albini (Portomaggiore 1895 – Roma 1973) Sottosegretario agli interni Fu condannato a morte in contumacia dal tribunale di Verona istituito dalla RSI nel gennaio 1944 Morto per morte naturale nel 1973 Foto Wikipedia | |
3. Dino Alfieri (Bologna 1886 – Milano 1966) Consigliere nazionale del Regno Fu condannato a morte in contumacia dal tribunale di Verona istituito dalla RSI nel gennaio 1944 Morto per morte naturale nel 1966 Foto Wikipedia | |
4. Giovanni Balella (Ravenna 1893 – Ravenna 1988) Presidente della Confederazione industriali Fu condannato a morte in contumacia dal tribunale di Verona istituito dalla RSI nel gennaio 1944 Morto per morte naturale nel 1988 Foto Wikipedia | |
5. Giuseppe Bastianini (Perugia 1899 – Milano 1961) Sottosegretario agli esteri Fu condannato a morte in contumacia dal tribunale di Verona istituito dalla RSI nel gennaio 1944 La Corte d’Assise speciale di Roma nel 1947 lo assolse da ogni accusa Morto per morte naturale nel 1961 Foto Wikipedia | |
6. Annio Bignardi (Bondeno 1907 – Ferrara 1985) Presidente della Confederazione lavoratori agricoltura Fu condannato a morte in contumacia dal tribunale di Verona istituito dalla RSI nel gennaio 1944 Morto per morte naturale nel 1985 Foto Istituto Luce | |
7. Giuseppe Bottai (Roma 1895 – Roma 1959) Membro del Gran Consiglio, Governatore di Roma Firmatario nel 1938 del “Manifesto della razza” Fu condannato a morte in contumacia dal tribunale di Verona istituito dalla RSI nel gennaio 1944 Morto per morte naturale nel 1967 Foto Wikipedia | |
8. Tullio Cianetti (Assisi 1899 – Maputo 1976) Ministro delle corporazioni Il giorno dopo Cianetti scrisse a Mussolini una lettera nella quale si dichiarava pentito del voto espresso. Al processo di Verona della RSI fu condannato a 30 anni per attenuanti. Alla caduta della Repubblica Sociale Morto per morte naturale nel 1976 Foto Wikipedia | |
9. Galeazzo Ciano (Livorno 1903 – Verona 1944) Consigliere nazionale del Regno, Ministro degli esteri Sposò Edda Mussolini la prima figlia di Benito Mussolini Fucilato l’11 gennaio 1944 a seguito del processo di Verona indetto dalla RSI. Mussolini non si mosse a salvare il genero Foto Wikipedia | |
10. Emilio De Bono (Cassano d’Adda 1866 – Verona 1944) Quadrumviro della marcia su Roma del 28 ottobre 1922 Fucilato l’11 gennaio 1944 a seguito del processo di Verona indetto dalla RSI Foto Wikipedia | |
11. Alberto de’ Stefani (Verona 1879 – Roma 1969) Economista Fu condannato a morte in contumacia dal tribunale di Verona istituito dalla RSI nel gennaio 1944 Finita la guerra fu deferito all’Alta corte di giustizia ed assolto nel 1947 dall’accusa di collaborazionismo col nazismo. Riabilitato e reintegrato nelle sue cariche universitarie Morto per morte naturale nel 1969 Foto Wikipedia | |
12. Alfredo De Marsico (Sala Consilina 1888 – Napoli 1985) Ministro di grazia e giustizia Fu condannato a morte in contumacia dal tribunale di Verona istituito dalla RSI nel gennaio 1944 Morto per morte naturale nel 1985 Foto Wikipedia | |
13. Cesare Maria De Vecchi (Casale Monferrato 1884 – Roma 1959) Quadrumviro della marcia su Roma del 28 ottobre 1922 Fu condannato a morte in contumacia dal tribunale di Verona istituito dalla RSI nel gennaio 1944 Morto per morte naturale nel 1959 Foto Wikipedia | |
14. Luigi Federzoni (Bologna 1878 – Roma 1967) Presidente dell’Accademia d’Italia Fu condannato a morte in contumacia dal tribunale di Verona istituito dalla RSI nel gennaio 1944 Nel 1945 l’Alta corte di giustizia lo condannò all’ergastolo, ma fu amnistiato nel 1947 Morto per morte naturale nel 1967 Foto Wikipedia | |
15. Luciano Gottardi (Ferrara 1899 – Verona 1944) Presidente della Confederazione lavoratori industria Fucilato l’11 gennaio 1944 a seguito del processo di Verona indetto dalla RSI foto mondoagricoloferrarese.it | |
16. Dino Grandi (Mordano 1895 – Bologna 1988) Presidente della Camera dei fasci e delle corporazioni Fu condannato a morte in contumacia dal tribunale di Verona istituito dalla RSI nel gennaio 1944 Morto per morte naturale nel 1988 Foto Wikipedia | |
17. Giovanni Marinelli (Adria 1879 – Verona 1944) Sottosegretario al Ministero delle comunicazioni Fucilato l’11 gennaio 1944 a seguito del processo di Verona indetto dalla RSI Foto Wikipedia | |
18. Carlo Pareschi (Poggio Renatico 1898 – Verona 1944) Ministro dell’agricoltura e delle foreste Fucilato l’11 gennaio 1944 a seguito del processo di Verona indetto dalla RSI Foto Wikipedia | |
19. Edmondo Rossoni (Tresigallo 1884 – Roma 1965) Sindacalista Fu condannato a morte in contumacia dal tribunale di Verona istituito dalla RSI nel gennaio 1944 Morto per morte naturale nel 1965 Foto Wikipedia |
n.8 (otto) voti contrari alla destituzione:
1. Carlo Alberto Biggini (Sarzana, 1902 – Padova, 1945) Ministro dell’educazione nazionale Fu uno dei ministri di primo piano dell’ultimo governo Mussolini a non venire fucilato Morto di malattia, ma in circostanze non chiare il 19/11/1945 | |
2. Guido Buffarini Guidi (Pisa, 17 agosto 1895 – Milano, 10 luglio 1945) Ministro dell’interno della Repubblica Sociale Italiana Ebbe gravi responsabilità nella consegna a Kappler di prigionieri da fucilare nelle Cave Ardeatine il 23 marzo 1943 Condannato a morte dalla Corte di Assise (dell’Italia liberata), fu fucilato il 10 luglio 1945 Foto Wikipedia | |
3. Roberto Farinacci (Isernia, 16 ottobre 1892 – Vimercate, 28 aprile 1945) Segretario del Partito Nazionale Fascista, il “Ras di Cremona” Fu catturato dai partigiani a Beverate e fu fucilato a Vimercate Foto Wikipedia | |
4. Ettore Frattari (Ravenna, 9 settembre 1896 – Roma, 12 luglio 1976) Presidente della Confederazione agricoltori Fu testimone durante il processo di Verona Morto di morte naturale | |
5. Enzo Galbiati (Monza, 23 maggio 1897 – Solbiate, 23 maggio 1982) Capo di stato maggiore della MVSN – Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale) Morto di morte naturale Foto Wikipedia | |
6. Gaetano Polverelli (Visso, 17 novembre 1886 – Anzio, 17 settembre 1960) Ministro della cultura popolare MINCULPOP Arrestato il 21 giugno 1944, dopo la liberazione di Roma (4-5 giugno 1944), nel dopoguerra venne processato e il 19 luglio 1946 assolto dalla Corte d’Appello di Roma. Si ritirò quindi a vita privata. Morto di morte naturale Foto Wikipedia | |
7. Carlo Scorza (Paola, 15 giugno 1897 – San Godenzo, 23 dicembre 1988) Segretario del PNF Arrestato, evade e si rifugia in Argentina, in seguito rientra in Italia. Morto di morte naturale Foto Wikipedia | |
8. Antonino Tringali Casanuova (Cecina, 10 maggio 1888 – Cremona, 1º novembre 1943) Presidente del Tribunale speciale Dopo l’8 settembre, aderì alla Repubblica Sociale Italiana e nel settembre del 1943 venne nominato Ministro di Grazia e Giustizia. Morto poco dopo il suo insediamento per un attacco di angina pectoris. |
unico astenuto
Giacomo Suardo (Bergamo 25 agosto 1883 – Bergamo 1947) Presidente del Senato del Regno Deferito all’Alta corte di giustizia per le sanzioni contro il fascismo nel 1944, venne dichiarato decaduto nell’ottobre dello stesso anno. Morto di morte naturale |
Dopo l’approvazione dell’O.d.G. Grandi, Mussolini ritenne inutile porre in votazione le altre mozioni e tolse la seduta.
Alle 2:40 del 25 luglio i presenti lasciarono la sala.
Nonostante possa sembrare quella di Dino Grandi una vittoria facile, netta e schiacciante, il risultato in realtà fu incerto fino alla fine. Si temevano defezioni e ripensamenti dell’ultimo minuto, in fondo il Duce, nonostante quella sera fosse parecchio malmesso, incuteva ancora soggezione e per molti presenti rappresentava ancora la loro guida, il loro padre politico, gli erano debitori… e Mussolini lo sapeva…
Le ragioni dei 19 del voto contrario erano chiare anche se variegate, solo la determinazione di Grandi le tenè unite. Per contro le ragioni del no (a favore del Duce) erano altrettanto variegate ma senza un leader che le tenesse assieme. Per il “no” era non un senso di sfiduzia verso la Cornona ma bensì un modo di tenere ben distinte le responsabilità del Monarca dalla grave situazione che la nazione stava vivendo (Biggini).
L’atteggiamento di Mussolini in quel 25 luglio è da analizzare a fondo. Nonostante poteva imporsi in vario modo sui presenti e fare l’ennesimo “scatto di reni” assunse invece un comportamento che pendolava tra il paternalista, l’irresponsabile presupponente, il puerile, il fatalista. Tutto nella stessa mente in quelle intense ore notturne (dalle 18:15 del 24 alle 2:40 del 25).
[…]
E’ necessario sottolineare ulteriormente, se mai ce ne fosse ancora la necessità, non solo l’entità del risultato, 19 a 8 più del doppio dei contrari, ma anche il peso di ogni singolo voto, il CHI votò a favore. Nulla di ovvio! Personaggi che poco o nulla si sarebbe pensato dare il voto di sfiducia. Quelli “nati con la camicia nera” come amava dire Mussolini.
Grandi diede la stura a tutti di vendicarsi per le promozioni mancate, per le prebende revocate, per le carriere soffocate… fu una notte di veleni e vendette.
Votarono a favore della destituzione addirittura i due quadrumviri Emilio De Bono (quadrumviro ma anche Governatore della Tripolitania e dell’Etiopia, Maresciallo d’Italia!) e Cesare Maria De Vecchi.
Votò a favore Galeazzo Ciano, ministro del mitico MinCulPop, ministro degli esteri e suo genero!
Votò a favore addirittura Giuseppe Bottai firmatario nel 1938 del “Manifesto della razza” (che Badoglio al suo insediamento non si preoccupò minimamente di abrogare).
[…]
Ed il Re? cosa avrebbe votato se gli fosse stato chiesto? non era da lui partecipare direttamente a certe questioni… tramava a suo modo, anche lui pendolando nel dire e nel non dire.
Riempiendosi la bocca di Patria e le tasche di petrolio (vedi gli intrighi
dietro al delitto Matteotti)…
[…]
E i vertici militari cosa avrebbero votato? I piemontesi monferrini tutti schierati col Re? e gli altri? Tutti neutrali per dovere? o stavano tramando anche loro?
[…]
In quella notte di tensione e di scontro nessuno era riuscito a prevedere delle mosse oltre a quelle di apertura 1.e4 c5… un voto contrario al Capo del Governo avrebbe aperto scenari di forte incertezza che le loro menti non avevano dovutamente considerato.
Il 25 luglio, quindi, fu la data della fine del fascismo istituzionale di governo a Roma, ma certamente non fu la fine del fascismo in Italia come pensiero politico e come forma di potere perché, di lì a pochi giorni, si ripropose in nuova forma per volere di Hitler alla guida della Repubblica Sociale Italiana, al cui comando sarà posto lo stesso Benito Mussolini. Non solo, ma in quel 25 luglio non ci fu di certo la condanna del fascismo e molti personaggi nei posti di comando locale e di vertice non si espressero mai in tal senso. Come detto la vergogna delle leggi razziali (per prendere ad esempio l’aspetto più eclatante) non fu cancellata, perchè tutti presi a salvare la loro posizione Re, Badoglio e i vari personaggi politici e militari al comando.
Nella testa dei votanti a favore della destituzione c’era la volonta di tornare al fascismo primigenio, quello puro di forte impronta sociale, quello della prima ora, il fascismo rivoluzionario che aveva infiammato (e illuso) gli animi. La destituzione era apparsa giustamente necessaria per la salvetta della Patria, ma il progetto non era connesso alla realtà, una realtà di insussitenza militare e industriale, di forti tensioni sociali, di pesante succubismo nei confronti del Reich.
Come si vedrà nei giorni successivi all’8 settembre, squallidi gerarchi ritirarono su la testa proprio per la presenza degli occupatori nazisti.
[…]
Il Re nominò il maresciallo Pietro Badoglio quale capo del governo, lo stesso 25 luglio. Prima il Re e poi Badoglio si affrettarono a disilludere subito il popolo italiano annunciando alla nazione che la guerra continuava.
Proclama del Re:
«Italiani, assumo da oggi il comando di tutte le forze armate. Nell’ora solenne che incombe sui destini della Patria ognuno riprenda il suo posto di dovere, di fede, di combattimento: nessuna deviazione deve essere tollerata, nessuna recriminazione può essere consentita. Ogni italiano si inchini dinanzi alle gravi ferite che hanno lacerato il sacro suolo della Patria. L’Italia, per il valore delle sue forze armate, per la decisa volontà di tutti i cittadini, ritroverà, nel rispetto delle istituzioni che ne hanno sempre confortata l’ascesa, la via della riscossa. Italiani, sono oggi più che mai indissolubilmente unito a Voi dalla incrollabile fede nella immortalità della Patria. Vittorio Emanuele».
Vedremo con gli antefatti e fatti dell’8 settembre 1943 quanto queste parole furono menzoniere nei confronti delle italiane e italiani.
Proclama di Badoglio:
«Italiani, per ordine di Sua Maestà il re e imperatore assumo il governo militare del Paese con pieni poteri. La guerra continua. L’Italia, duramente colpita nelle sue province invase, nellesue città distrutte, mantiene fede alla parola data, gelosa custode delle sue millenarie tradizioni. Si serrino le file intorno a Sua Maestà il re e imperatore, immagine vivente della Patria, esempio a tutti. La consegna ricevuta è chiara e precisa: sarà scrupolosamente eseguita e chiunque si illuda di potere intralciare il normale svolgimento, o tenti di turbare l’ordine pubblico, sarà inesorabilmente colpito. Viva l’Italia. Viva il re. Maresciallo d’Italia Pietro Badoglio».
Già dal 26 luglio fu applicato il consueto metodo da regime: nessun passaggio parlamentare, nessuna concessione al popolo, i poteri civili venivano assorbiti dal potere militare, massima repressione instituendo anche il coprifuoco, assembramenti vietati, massima censura sui giornali, vietata la stampa di manifesti e volantini. Badoglio in una circolare alle truppe che dovevano controllare l’ordine pubblico disse: “Poco sangue versato inizialmente risparmia fiumi di sangue in seguito.” Il governo Badoglio voluto dal Re dopo il 25 luglio non ebbe mai l’appoggio delle forze popolari perché ancora troppo legato al precedente esautorato governo fascista. Di novità positive per il popolo non se ne vedevano: un Maresciallo d’Italia a capo del Governo al posto di un Duce, la guerra rimaneva guerra, la repressione rimaneva e la fame rimaneva fame.
In quel quadro di cambio vertiginoso di comando, con Mussolini amico, protetto e alleato di Hitler, la reazione germanica era prevedibile: l’Italia era divenuta terra di conquista e occupazione.
il Re e Badoglio non furono in grado di gestire le conseguenze politico-militari di questo cambio e non si preoccuparono minimamente (sperando di non irritare ulteriormente l’alleato) di controllare le mosse dei tedeschi che non persero tempo inviarono dopo il 25 luglio altre 19 divisioni in Italia, quadruplicando le loro forze; l’Italia quindi si ritrovò in parte occupata dagli
anglo-americani ed in parte dai nazifascisti a seguito dell’attuazione parziale
anticipata del piano Alarico che prevedeva l’occupazione dell’Italia da parte dei germanici in caso di suo ritiro dal conflitto. In sostanza fu l’inizio della guerra civile.
[…]
“…falli arrestare tutti prima che sia troppo tardi… ”
(donna Rachele la domenica mattina del 25 aprile a Mussolini)
“… non ti preoccupare verranno tutti come sempre a chiedermi scusa e a ritrattare la loro scelta…”
(Mussolini prima di andare dal Re)
[…]
“Falli arrestare tutti”… avrebbe potuto ancora il Duce, nonostante il netto voto a suo sfavore, ribaltare le sorti e non essere deposto? i militari lo avrebbero ostacolato? La sua Milizia sarebbe intervenuta a difesa del Capo?
Le folle osannanti in piazza con naso all’insù verso il Balcone avrebbero invaso le piazze per chiedere la sua rimessa al potere?
Come testimoniò dopo la guerra Dollmann (diplomatico tedesco vicino al Vaticano), con non poca soddisfazione, nessuno si fece vedere subito dopo il 25 luglio all’Ambasciata tedesca a Roma. I pochi che si affacciarono stavano lì per chiedere protezione e aiuto. Nessuno chiese dov’era il loro duce. Nessuno si mosse a sua protezione.
[segue]
Estratto dal libro di Luca Lestingi:
“45 giorni e 80 anni: dal 25 luglio all’8 settembre 1943
passando per l’oggi – Come non abbiamo ancora superato gli eventi di
quel periodo“
1943 25luglio 25luglio1943 badoglio cadutafascismo casematte casematteroma casematteroma1943 destituzionemussolini finefascismo granconsigliodelfascismo liberazione ordinedelgiornograndi ordinegrandi proclamabadoglio proclamarevittorioemanuele revittorioemanueleIII roma roma1943 seconda guerra mondiale seconda guerra mondiale roma storia storiadItalia storiamilitare vittorioemanueleIII